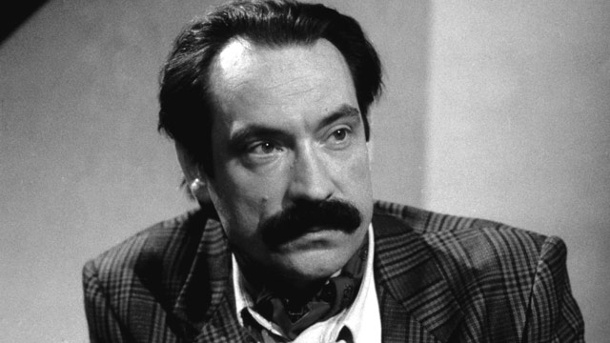“Il romanzo della parola: incontro con Sebastiano Vassalli”. È questo il tema del seminario promosso dal Laboratorio di scrittura e cultura della comunicazione della facoltà di Scienze della comunicazione dell’università La Sapienza di Roma, in collaborazione con la casa editrice Einaudi. Tre giornate: l’8, il 15 e il 21 marzo (ore 15-17) in aula Wolf, con la proiezione di filmati delle teche Rai e letture di brani delle opere di Sebastiano Vassalli. A concludere ci sarà l’incontro con lo scrittore il 28 del mese, al centro congressi di via Salaria 113 (ore 14-18). Il ciclo di lezioni, curato da Maurizio Zuccari, vede la partecipazione, oltre che di Vassalli, del direttore editoriale Einaudi Stile libero Severino Cesari e del preside della Facoltà, Mario Morcellini, di Roberto Cicala e di Cristina Nesi, esperti della vita e delle opere dello scrittore. Il seminario intende ripercorrere le tappe fondamentali di Vassalli, dall’esordio letterario degli anni sessanta con le avanguardie del Gruppo 63 al successo di critica e pubblico della Chimera (premio Strega 1990), al recente La Morte di Marx e altri racconti. La facoltà di Scienze della comunicazione del più grande ateneo d’Europa apre dunque le porte a uno tra i maggiori scrittori contemporanei, solitamente schivo e distante dal mondo dei media, che ha segnato il panorama dell’ultimo trentennio. Il seminario per la prima volta darà l’opportunità a scrittore e studenti, scrittura viva e in farsi, di confrontarsi in un’aula universitaria.
Programma seminario
Mercoledì 8 marzo
Ore 15-17, aula Wolf (via Salaria 113, primo piano)
La stagione della Neoavanguardia: gli anni ’60 e ‘70
Ore 15 – Presentazione, inquadramento dell’autore e dell’opera
Primo video sul Gruppo 63 del ’79, id. teca C26509 (20 minuti)
Letture da: Il millennio che muore, Narcisso, Tempo di màssacro, L’utopia ceramica (15 minuti) e domande (15 minuti)
Pausa (10 minuti)
Ore 16 – Letture da: L’arrivo della lozione, Abitare il vento, Mareblù (15 minuti) e domande (15 minuti)
La curiosità: Vassalli alias Stephen Blacktorn: Sesso ® (letture) e domande (10 minuti). Secondo video: intervista al liceo Socrate di Napoli su memoria e scrittura, 28-1-99, id. teca P99027/00 (20 minuti).
Mercoledì 15 marzo
Ore 15-17, aula Wolf
Dalla transizione al successo: gli anni ’80, lo Strega del ’90. Campana “babbo matto”
Riepilogo lezioni precedenti, proiezione intervista precedente (seconda parte, 20 minuti)
Letture da: Arkadia, La notte della cometa, Sangue e suolo, Viaggio fra gli italiani trasparenti, L’alcova elettrica e domande (30 minuti)
Pausa (10 minuti)
Secondo video: La Chimera, 13-7-9O, id. teca T90194/431 (20 minuti)
Letture da: L’oro del mondo, La chimera, La chimera. Storia e fortuna del romanzo di Sebastiano Vassalli, Belle lettere (cit. da Cicala, 15 minuti)
La curiosità: Il neoitaliano (letture) e domande (10 minuti)
Martedì 21 marzo
Ore 15-17, aula Wolf
Le opere della maturità: l’ultimo quindicennio. Il romanzo della parola
Riepilogo lezioni precedenti e presentazione dell’ospite: Cristina Nesi
Primo video: intervista su risaie e Biandrate, 10-8-99, id. teca F276329 (10 minuti)
Interventi di Roberto Cicala e Cristina Nesi, letture da Sebastiano Vassalli (Cadmo) e Terra e acque (Interlinea) e domande (30 minuti). Letture da: 3012, La notte del lupo, Un infinito numero e domande (10 minuti)
Pausa (10 minuti)
Proiezione video: intervista su Amore lontano, 15-7-05, id. teca F465939 (10 minuti)
Letture da: Stella avvelenata, Amore lontano, La morte di Marx e altri racconti e domande (20 minuti)
La curiosità: Gli italiani sono gli altri, Belle lettere (letture) e domande (10 minuti)
Martedì 28 marzo
Ore 14-18 centro congressi via Salaria 113
Incontro con lo scrittore. Dalla morte di Marx all’ipotesi di una nuova letteratura
Saluto del preside, presentazione ospiti: Sebastiano Vassalli e Severino Cesari. Proiezione materiali Rai, direzione teche (15 minuti circa): intervista su Amore lontano, 7-8-05, id. teca T05220/114
Interventi ospiti, domande e dibattito dal palco
Ore 15.45 pausa
Letture da: La morte di Marx e altri racconti. Domande e intervento Vassalli, domande dal pubblico
Il romanzo della parola
Ogni volta che il miracolo della poesia torna ripetersi, sembra che quella volta debba essere l’ultima. L’esistenza dei poeti è sempre più precaria, il mondo intorno a loro è sempre più complicato e distratto, la società delle persone colte è sempre più dominata dagli intellettuali alla moda (come Tommaseo), ed è sempre più ostile nei confronti di chi (come Leopardi) non si riconosce nei suoi slogan e nelle sue effimere verità. Ma il miracolo accade, di tanto in tanto, e continuerà ad accadere finché esisterà un filo di parole che unisce gli uomini con qualcosa al di fuori del loro mondo. Con un’entità, a cui noi non sappiamo dare altro nome che quello di Dio: e chissà poi cos’è davvero! Ho detto che la poesia è un miracolo. Cercherò di spiegarmi. Un miracolo, secondo i dizionari, è qualcosa che avviene nonostante le leggi che governano la natura, per opera di forze soprannaturali. Non tutte le religioni che ci sono oggi nel mondo ammettono i miracoli; ma, anche là dove gli eventi prodigiosi vengono riconosciuti come possibili, la loro memoria è breve e la loro funzione è modesta. Chi si ricorda più, oggi, degli Dei etruschi? Eppure i loro templi erano pieni di “ex voto” in terracotta che rappresentavano parti del corpo umano: gambe, braccia, fegati, milze eccetera, guarite in seguito ad altrettanti interventi soprannaturali della divinità. Chi si ricorda più delle piogge di pietre, e delle piogge di sangue, di cui parlano, senza manifestare il minimo dubbio, gli storici dell’antica Roma? Chi si ricorda dei roseti fioriti in pieno inverno, dei leoni addomesticati e degli altri innumerevoli prodigi compiuti dai santi cristiani?
Nel buio della memoria
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
Il mondo, e più di lor non si ragiona
L’unico miracolo che si compie dai tempi di Omero e da prima ancora, e che non può essere dimenticato o messo in dubbio perché chiunque può farlo rivivere con la lettura, è quello delle parole che trattengono la vita. È la poesia. La poesia è vita che rimane impigliata in una trama di parole. Vita che vive al di fuori di un corpo, e quindi anche fuori dal tempo. Vita che si paga con la vita: le storie che ho raccontato in questo libro stanno a dimostrarlo. La poesia è ciò che sopravvive, nel presente, della parola di cui parlano i testi antichi, che «viene prima di tutto e che dà la vita a tutto». E’ l’unico miracolo possibile e reale, in un mondo dominato dal frastuono e dall’insensatezza. È la voce di Dio. (da Amore lontano)
Perché Vassalli: autore da Pleiadi, interprete del suo tempo ma distante da esso. Pochi come lui hanno saputo combinare sperimentalismo e tradizione, cercando di andare alle origini del presente: un maestro, più che un intellettuale. E difatti è stato maestro, prima che pittore, poeta, scrittore…
Scheda bio-bibliografica sullo scrittore
La stagione della Neoavanguardia, gli anni ’60 e ‘70
Sebastiano Vassalli è nato a Genova nel 1941 da padre milanese e madre toscana ma è praticamente vissuto sempre a Novara. Tra gli anni ’60 e ’70 ha svolto attività di insegnante dal ’65 al ’79 (è laureato in Lettere all’Università degli studi di Milano con una tesi sull’arte contemporanea e la psicanalisi), partecipando, in un primo momento come pittore, autore di testi teatrali (L’uccello di Dio, Il mazzo) e poeta, poi fondando riviste quali “Ant. End.” e “Pianura”, alle vicende della neoavanguardia nell’ambito del Gruppo 63, con alcune prose sperimentali (Narcisso è del 1968, Il millennio che muore è del 1972, cui precede Tempo di màssacro e segue L’utopia ceramica del 1974, ma scritto precedentemente) dove si travasano nella pagina, con furore linguistico, le inquietudini politico-sociali di quegli anni. Il movimento, nato al convegno di Palermo del ’63, riconvocato per anni in altri luoghi (tra cui Fano nel ’67, cui partecipa il nostro), all’interno di una società a capitalismo avanzato mira a liquidare la cultura ufficiale e tentare nuove strade recuperando la tradizione dell’avanguardia del Primo Novecento, sottraendo alla letteratura ogni pretesa di verità e privilegio, allargando anche e destrutturando il linguaggio verso il quotidiano, il gergo, il settoriale. L’arrivo della lozione (1976) è l’ultimo frutto della stagione che produce, oltre ai citati libri in prosa, le raccolte in versi Lui (1965), Disfaso (1969), poi Brindisi (1979), Belle lettere (1979), La distanza (1980), queste ultime tre raccolte nella miniantologia Ombre e destini (1983).
La transizione e il nuovo corso: gli anni ‘80
Rispetto a queste esperienze giovanili, Abitare il vento del 1980 segna un distacco e una svolta. Il protagonista, come nel successivo Mareblù, è incapace di cambiare il mondo con metodi rivoluzionari e vive un riflusso al pari dei tempi, fino ad annientarsi fisicamente e simbolicamente. Del furore gergale restano tracce dissimulate sotto una coltre d’ironia amara. Qui cominciano a prendere corpo storie e personaggi riconoscibili, preannunciandosi il gusto per la storia, il romanzo “storico” e la nuova stagione dei ripensamenti ideologici e letterari. I conti con un passato che oramai considera imbelle e concluso sono dell’83, con il libello Arkadia. Da un anno vive nella canonica di Pisnengo (NO).
Vassalli cerca quindi nuovi personaggi, una letteratura capace di affondare nel passato per capire l’oggi, di andare alle origini della società odierna e una dimensione esistenziale anch’essa pura, come la fanciullezza o la follia. In questo senso è per lui emblematico il poeta Dino Campana (riproposto nella Notte della cometa e nella prefazione ai Canti Orfici), definito dallo scrittore il suo “babbo matto” per la sua avversione alle avanguardie e la lotta all’industria del cadavere del tempo, come per l’essere uomo fuori del tempo.
Il romanzo storico e la ricerca sul nostro carattere nazionale: gli anni ’90
È di questo periodo la deriva verso la saggistica, o meglio il saggio romanzato, con L’alcova elettrica, sorta d’appendice al precedente, e Sangue e suolo, libro-inchiesta sugli “italiani trasparenti” in Alto Adige che preannuncia quello che sarà il ciclo narrativo seguente, il corpus dell’opera dello scrittore, aperto da L’oro del mondo (1987), ambientato nel dopoguerra, popolato da personaggi marginali che escono dal fascismo e sui quali sta per abbattersi il progresso: un grande affresco pluriepocale su vizi e virtù del nostro paese, con la costante attenzione al rimosso, al represso fatti o genti nascoste dietro verità di comodo, precotte. Al vertice e al centro della ricerca c’è La chimera, ambientato in un villaggio padano del ‘600, premio Strega e grande successo editoriale del 1990 (dall’anno precedente si è trasferito nella canonica di Biandrate). La carrellata nel tempo prosegue nel Settecento di Marco e Mattio, uscito l’anno dopo, quindi all’Ottocento e agli inizi del Novecento con Il Cigno nel 1993 e, dopo la parentesi fantascientifica e satirica di 3012, con Cuore di pietra (1997), dove ricrea la storia dall’unità d’Italia ad oggi attraverso una grande casa di Novara. Intanto Vassalli non smette di indagare il suo paese con i pamphlet Il neoitaliano (1991), cui segue Gli italiani sono gli altri (1998, poi 2003), raccolta degli articoli apparsi come opinionista del “Corriere della Sera”. L’investigazione letteraria delle radici e dei segni di un passato che illumini il presente e ricostruisca il carattere nazionale degli italiani approda quindi a La notte del lupo, Baldini & Castoldi, 1998; Un infinito numero, Torino, Einaudi, 1999, viaggio di Virgilio nell’Etruria alla riscoperta di un passato arcaico e oscuro. La fine di una stagione di impegno civile e di lotte generazionali fa invece da contraltare al successivo Archeologia del presente, ivi, 2001. Dopo la parentesi del minipamphlet Dux, ivi, 2002 con Casanova “arcitaliano”, summa di vizi e virtù; il ritorno al romanzo “storico” si ha con Stella avvelenata, ivi, 2003; che rievocando la vicenda della “vera” scoperta delle Americhe torna sul tema dell’utopia e della disillusione.
L’oggi: il romanzo della parola e la ricerca di una nuova letteratura
Da qui le prove più recenti riguardano il recupero della funzione “sacrale” della parola attraverso il suo romanzo, o meglio la poesia, in Amore lontano, ivi, 2005; storie di vita e di morte di sei fra i maggiori poeti di ogni tempo. Con l’ultimo La morte di Marx e altri racconti, ivi, 2006, infine, è appunto questa la cifra narrativa usata, per la prima volta, per affrontare il tema di un’uguaglianza che avrebbe livellato verso il basso ogni comportamento e sensibilità umana: di qui la necessità di reinventare, persino, una nuova letteratura. Rispetto al corpus di queste opere le esperienze poetiche pubblicate dalla casa editrice Il bagatto (riproposte in parte dall’editore Guida con Ombre e destini), la corrispondenza con il giornalista Attilio Lolini (Belle lettere, Einaudi) e, più recentemente, la saggistica mirata al territorio, con Il mio Piemonte, Interlinea, 2002; Terra d’acque, ivi, 2005, rappresentano percorsi paralleli di una costante ricerca del rapporto tra scrittura e vissuto.
Bibliografia delle opere
Lui (egli), Quaderni del Preconsole, Firenze, 1965; (poesia); Narcisso, Einaudi, Torino, 1968; Disfaso, Trevi, Roma, 1969; Tempo di màssacro. Romanzo di centramento & sterminio, Einaudi, 1970; Stephen Blacktorn, alias S. V., Sesso ®, Dellavalle, Torino 1970; Il millennio che muore, Einaudi, 1972; L’utopia ceramica, Longo, Ravenna, 1974; L’arrivo della lozione, Einaudi, 1976; Abitare il vento, ivi, 1980; Mareblù, Milano, Mondadori, 1982; ivi,1990); Manuale di corpo, Siena, Quaderni di Barbablù, 1983; Milano, Leonardo, 1991, con note di C. Fini; Arkadia, Bergamo, El Bagatt, 1983; Ombre e destini, Napoli, Guida, 1983 (poesia); Sangue e suolo. Viaggio fra gli italiani trasparenti, Torino, Einaudi, 1985; La notte della cometa. Il romanzo di Dino Campana, ivi, 1984; L’oro del mondo, ivi, 1985; L’alcova elettrica. 1913: il futurismo italiano processato per oltraggio al pudore, ivi, 1985; Il neoitaliano. Le parole degli anni Ottanta, Bologna, Zanichelli, 1989 (nuova edizione «In appendice: le parole del 1990», ivi, 1991); La chimera, Torino, Einaudi, 1990 (ristampato innumerevoli volte, anche edizione scolastica e all’estero; Belle lettere, con A. Lolini, ivi, 1991; Marco e Mattio, ivi, 1992; Il cigno, ivi, 1993; 3012, ivi, 1995; Cuore di pietra, ivi, 1997; La notte del lupo, Milano, Baldini & Castoldi, 1998; Gli italiani sono gli altri, ivi, 1998 (poi 2003); Un infinito numero, Torino, Einaudi, 1999, Archeologia del presente, ivi, 2001; Dux, ivi, 2002; Il mio Piemonte, Novara, Interlinea, 2002; Stella avvelenata, Torino, Einaudi, 2003; Amore lontano, ivi, 2005; Terra d’acque, con presentazione di R. Cicala, Interlinea, Novara 2005; La morte di Marx e altri racconti, Einaudi 2006.
Opere
Narcisso è un guitto della parola scritta, anima bella e pornofonista, è al centro del romanzo d’esordio di Vassalli nella Ricerca letteraria curata da Guido Davico Bonino, Edoardo Sanguineti e Giorgio Manganelli (sua la prefazione al volumetto). Una prosa fonica, una festa della parola, un’euforica bisboccia verbale.
Disfaso (1969) contiene diciotto prose (?) edite da Trevi. Quarantacinque paginette racchiuse da un cartonato giallino, nonsense di lingua e stile, ratatouille semantico. Con Disfaso è al suo terzo libro – dice il prefatore Franco Cavallo – o meglio al suo terzo esperimento, sulla scia della polverizzazione della lingua e del suo significare. Destrutturare la logica del pensiero e della parola per dire non significando nulla, ma per necessità di significare: «Che è, come dire, che cacare è una necessità biologica e chi non caca muore. Vassalli è uno che progetta di andarsene in giro a vendere pietre filosofali, comuni pietre raccolte nei fossati attorno a Novara. Un teorico del disimpegno a oltranza o dell’impegno totale, che è la stessa cosa; un nuovo tipo di anarchico che tende a istituzionalizzare l’inutile; una specie di peone che sostiene come la rivoluzione si può fare anche rimanendosene a dormire accosciati contro un muro scazzottato dal sole. L’importante non è avere gli occhi aperti, ma la coscienza sveglia».
Sesso ® è prefato e tradotto, di fatto scritto da Vassalli questo pamphlet o “piccola enciclopedia universale di fantasesso” è un divertissement letterario, ripudiato dall’autore, che raccoglie il meglio (?) della letteratura erotica fantascientifica degli anni ’60, da Dick a Ballard.
Coèvo ad esso è un altro pamphlet, Tempo di màssacro, di tutt’altro segno. Se il precedente Narcisso era per Giorgio Manganelli una furibonda festa della parola, un’euforica bisboccia verbale, non è da meno questo trattatello scandito da paragrafi che riecheggiano la trattazione tardorinascimentale e barocca. La vita è violenza, sopraffazione, sterminio: Vassalli offre dunque una funambolica catalogazione de la guerra individuale, di gruppo o di popolo, una carrellata sulle orrifiche e regressive sorti dell’umano consorzio. E lo fa con un linguaggio aulico e al tempo stesso inquietante.
Il millennio che muore. Di Bonino è invece la prefazione alla terza prova letteraria (la seconda nella Ricerca) dove la cadenza si fa più misurata, il furore espressionistico del primo Vassalli sembra placarsi, dice, ma il pessimismo ilare e atroce è condensato in una gnome (motto) ancora più scettica e compatta. Nelle lasse (serie di versi) di questa terza odissea, tra le macerie del Tutto, il pamphlet appare come un punto d’arrivo e partenza verso nuovi territori. Dopo l’Io degli esordi è già un romanzo della parola in farsi, questo: «Perché l’Io era verbo, e il mondo impasto di materia informe e linguaggio da cui nascevan le cose e gli uomini, era bianco di pagina su cui le parole si univano».
Il libro dell’utopia ceramica. Scritto tra il ’69 e il ’71 ma apparso con qualche anno di ritardo, è ancora un atto d’accusa al mito del progresso, dove l’io resta soggetto narrante (il piastrellante archetipo, il ceramista) di storie (esagoni ceramici) che si compongono e scompongono in un intreccio a caso. Qui nasce la passione per la storia che si fa mito per essere narrata e diviene utopia per essere modificata (da una diversa concezione dell’io). Dunque, l’utopia ceramica è la piastrellizzazione del mondo, la metamorfosi dal caos iniziale delle Stalle di Augia al cesso svedese.
La poesia oggi, Quaderni di “Ant.ed”, 1971, con un disegno di Carlo Cremaschi (1965) in copertina, stampato dalla tipografia Mora grafica (Novara). Dalla premessa dell’autore: «La poesia oggi esibisce modestissimi orpelli di décor… non distende pietosamente la parola come un velo a coprire il baratro che s’è aperto tra le cose e i termini che le designano; conosce nell’ambito della parola stessa la condizione di un mondo dominato da cieca violenza e astrazioni innominabili. Dunque questa poesia, prosaica e didascalica fin che si vuole, ha tuttavia alcuni grandi meriti: non si muove in una sfera estetica, non cerca di commuovere evocando fantasmi per mezzo di parole non più adatte a tale scopo, non costruisce slogan per la pubblicità o alibi per la presunzione degli stupidi. La poesia oggi non vuole incantare nessuno, e perciò non inganna nessuno. Parla delle cose così come esse realmente stanno… Dichiariamo pure a scanso di equivoci che non è arte, è linguaggio applicato, discorso… La poesia oggi nasce dalla compiuta conoscenza e dal rifiuto dello sperimentalismo, dell’avanguardia e quindi dell’arte borghese. Ovviamente, non si rivolge al passato, ma al futuro. È da poco iniziata l’età dell’Acquario, più di metà della popolazione terrestre non sa ancora leggere né scrivere. Questa è una realtà tale da ispirare la certezza che, se anche è stata scritta della grande poesia nelle epoche passate, ancora molta ne rimane da scrivere. Ma l’arte, quella bisognerà proprio buttarla via, come una mela marcia».
L’arte e la letteratura devono affrontare la violenza, la demenza sul loro stesso terreno, in una partita contro l’oscuro che né la politica né la scienza potrebbero giocare sul serio. Da questa convinzione discende il successivo L’arrivo della lozione (1976). Dello stile precedente resta una traccia nel procedere per paragrafi, elisioni e metafore, ma la storia è più tradizionale, s’affaccia il romanzo. Al centro è ancora la violenza, negli anni di piombo e delle bombe. E l’indagine si focalizza, in questa “storia di Murgia e dintorni”, in Benito Chetorni, figlio di Emanuele Vittorio e Italia Nostra, vale a dire nell’ambiente umano e sociale, nell’humus in cui nasce e si forma quel che Guido Castelli avrebbe definito “Il fascistibile”: qualunquista da strapaese e massa di manovra nella strategia della tensione. Il nostro recita la parte d’un gazzettiere per scavare alle radici del male, del mostro, con digressioni dove l’ironia prevale sull’amarezza.
Abitare il vento (le ideologie come la pianura padana) esplora la fine del movimento, il tracollo delle ideologie e il riflusso personificato in Cristiano Rigotti detto Cris (crisi, Cristo?), un balordo appassionato di enigmistica in cerca di rivincita che si atteggia a cavaliere solitario degli spaghetti western. Invischiato in un sequestro, finisce la sua esperienza, politica ed esistenziale, a somma zero.
Mareblù coincide con il trasferimento a Pisnengo (ad abitare il vento), in una canonica in affitto, e con il sessantennale del Pci. In crisi qui non è più solo e tanto il militante o il movimento, quanto il partito, il sistema dei valori che lo sottende, l’ideologia che, da lì a qualche anno, sarebbe miseramente crollata. Augusto Ricci, anziano custode del camping che dà il titolo all’opera, è in procinto d’essere licenziato, conteso tra anziane matrone con cui cerca una sistemazione, represso e blandito da capitalisti astuti. Si sfoga parlando ai quattro grandi (Marx, Lenin, Stalin e Mao) appesi in camera, spiando le turiste e meditando un’impossibile rivincita ma il finale qui si scioglie nel grottesco, in una risata liberatoria e anarcoide.
Ombre e destini, miniantologia poetica. Quattordici anni di ricerche portano al romanzo-verità su Dino Campana, poerta folle e babbo matto putativo del nostro, che in alcuni tratti – anche per quel fenomeno d’innamoramento dell’autore con la sua opera – s’identifica in esso, vittima dello scontro con famiglia, paese natale e società letteraria del tempo (l’industria del cadavere). Come il poeta morto in manicomio, il nostro si scontra con tali entità, e pare compiacersi delle polemiche scaturite dal libro. Cfr. Gli italiani sono gli altri, p. 113, e Belle lettere, p. 10-16 . Di Dino Campana Vassalli curerà i Canti Orfici e altri scritti, insieme a Carlo Fini, di lì a qualche anno (Tea 1989).
Seguito da Sangue e suolo, viaggio tra gli italiani trasparenti – reportage dei numerosi viaggi fatti dall’autore in Alto Adige e in Germania per un’inchiesta sul bilinguismo commissionata da Bollati per “Panorama mese”, dove emerge l’apartheid di una minoranza che si tutela in quanto tale e governa in quanto maggioranza – il romanzo su Dino Campana ha un’appendice, gustosa, ne L’alcova elettrica. Stessa struttura narrativa e impasto stilistico per raccontare le vicende di un processo del 1913 per oltraggio al pudore ad un redattore della neonata rivista “Lacerba” diretta da Giovanni Papini, tale Italo Tavolato.
Dell’anno successivo (1987) è il primo passo compiuto in direzione del nuovo corso del romanzo “storico”. Muovendosi su un triplice livello narrativo, tra l’autobiografia favolosa e reale e l’epica stracciona del sottobosco padano, L’oro del mondo racconta le vicende di Sebastiano e al tempo stesso l’italietta che tenta di rifarsi una verginità dopo il fascismo, in attesa d’essere travolta dal boom economico.
La chimera, premio Strega del ’90, è tra i romanzi più venduti e tradotti dell’ultimo decennio del secolo scorso. Segna l’apoteosi dell’autore: un successo e una notorietà mai più raggiunti che lo fanno accostare a Manzoni (o meglio, ad un anti Manzoni, ateo e disincantato). Romanzo tradizionalissimo nel senso del termine, rappresenta un tuffo nel passato, nel Seicentesco villaggio di Zardino sparito dalla piana padana dopo una piena del Sesia, per narrare le vicende di Antonia Spagnoletti, ventenne arsa sul rogo come strega. E per raccontare, attraverso una storia emblematica del passato rimosso, il nulla dell’oggi. La chimera. Storia e fortuna del romanzo di Sebastiano Vassalli con testi dello scrittore, a cura di Roberto Cicala e Giovanni Tesio, è edita da Interlinea, nel 2003.
Mentre scrive la Chimera, Vassalli si impegna a raccontare Il neoitaliano, le parole degli anni ’80 (con un’appendice dei ’90). Agile volumetto bizzoso e ironico, dove i segni grafici fanno da contrappunto all’evolversi del linguaggio nel corso di quegli anni, “banali” a paragone dei “favolosi” e “folli” precedenti.
Sull’onda del successo editoriale de La chimera, Vassalli pubblica Belle lettere – titolo anche di un suo precedente volumetto di poesie edito dal Bagatt – libricino di sfoghi epistolari con l’amico Attilio Lolini (giornalista del quotidiano “l’Unità”, poi del “Manifesto” presente anche con scritti suoi) e altri, da cui emergono tratti del vissuto e della personalità del nostro.
Marco e Mattio segue nel ’92. Dedicato simbolicamente ai matti, testimonia ilo costante interesse verso il diverso e sommerso con un tuffo nel ‘700 non ancora del Lumi, il viaggio verso la follia di un pover’uomo, Mattio Lovat, e del suo diabolico compagno di strada. Più tetro e meno riuscito del precedente, e perciò di minor successo commerciale.
Il cigno (1993) è “il romanzo della mafia”. Il più storico in senso tradizionale, probabilmente anche il meno riuscito, narra di un omicidio eccellente nella Sicilia di fine ‘800 e dell’onorevole Raffaele Palizzolo, l’uomo d’onore che dà il titolo all’opera.
Con il successivo 3012 Vassalli punta la sua macchina del tempo sul futuro remoto per narrare, con le vicende di un altro povero cristo, Antalo, un Cristo alla rovescia, portatore di normalità e bontà in un mondo pacificato e normalizzato (piastrellizzato), ma passato alla storia come profeta del Male, teorizzatore del ritorno all’odio, più desiderabile e vitale del Bene. L’odio come motore della vita, il lato oscuro ma per questo più vero dell’altro, solare e pulito. Una provocazione e al tempo stesso un’amara constatazione, un domani se possibile ancora peggiore dell’oggi.
Con Cuore di pietra Vassalli racconta, per la prima volta esplicitamente, il carattere nazionale degli italiani attraverso la storia di una casa, la sua vita attraverso le famiglie che la abitano, in una città non detta che è la sua Novara, dall’Unità ad oggi.
E proprio al nostro carattere nazionale è dedicata la raccolta di articoli usciti su “Repubblica” e il “Corriere della Sera”, editi nel ’98: un viaggio in undici tappe sui piccoli-grandi fatti di cronaca per raccontare che gli italiani (non) sono gli altri.
La notte del lupo, coèvo al precedente, muove proprio dalle vicende del Cristo reale (?) o meglio di Giuda di Quériot e del suo doppio contemporaneo Ali Agca, per narrare con un disfaso temporale l’intrecciarsi di menzogne, il rincorrersi di mistificazioni che, dall’inizio dell’era cristiana, rovesciano il vissuto nel suo contrario e lo rendono mito, annullandolo.
Ultimo e forse meglio riuscito sforzo letterario del decennio – e prima opera a non partecipare ai premi letterari per volontà dell’autore – Un infinito numero è un viaggio nel passato remoto, alle origini di Roma e della nostra civiltà, sulle orme di Mecenate, Virgilio e del suo schiavo Timodemo, del loro viaggio in Etruria alla ricerca del materiale che avrebbe fornito la base dell’Eneide e del mito fondativo di Roma voluto da Ottaviano. L’io narrante, Timodemo, svela con un oscuro passato di pulizie etniche primigenie e di stupri di massa anche le ragioni più profonde della storia, l’inutilità stessa dello scrivere e del narrare, come pensavano gli antichi Rasna.
Il nuovo millennio si apre con due opere minori, ancora sul tema del nostro carattere nazionale. Archeologia del presente racconta di una coppia, Leo e Michela, come ritratto d’una generazione che sognava di cambiare il mondo e del loro fallimento, degli ultimi trent’anni e della fine d’ogni utopia. Di un vissuto che è, rispetto al presente, appunto archeologico. Ad essa segue un libricino, Dux, sull’ultimo scorcio di vita di Casanova nel castello boemo di Waldstein. Base dello scritto sono le ventuno lettere autografe dove il veneziano parla di sé, somma di vizi e virtù del Belpaese.
Stella avvelenata (2003) è il ritorno al romanzo classico, o meglio al racconto di un romanzo. Lo stile resta didascalico, rarefatto, come ormai è una costante di Vassalli Al centro del romanzo, ancora una volta la fallacità dei sogni, la loro propensione a divenire incubi.
«L’America prima dell’America. Una navigazione alla ricerca della mitica Atlantide, una scoperta prima del tempo, un viaggio al termine dei sogni e delle illusioni umane». Al termine dei sogni e delle illusioni umane. Così, l’ultima di copertina racconta in quattro righi le 238 pagine contenute nell’ultimo libro di Sebastiano Vassalli. Uno nato in un porto di mare che non gli ha lasciato addosso sale e finito a vivere sotto al Monte Rosa. In un piattume che neanche più la nebbia si degna di coprire. Ma questo scrittore, tra i migliori contemporanei, che ha fatto della storia la matrice dei suoi racconti – anche se lui, di queste etichette, se ne ride e se ne frega – stavolta al mare ha dedicato quest’ultimo suo racconto. Storia d’un viaggio collocato indietro nel tempo, più indietro di quel Seicento che, con la “strega” Antonia della Chimera, gli ha regalato notorietà facendogli saltare a piè pari lo sperimentalismo delle origini che pure ha consegnato ai posteri robetta non da poco: valga per tutti L’arrivo della lozione. Più indietro d’ogni altra epoca se si eccettua la fondazione del mito di Roma con Un infinito numero. Siamo dunque al mezzo del ‘400 quando tal Leonardo Sacco, chierico di Casale Monferrato, s’avvia verso Parigi dotato d’una scarsella che presto troverà altre saccocce e di sogni che s’infrangeranno su altri lidi. Su quelli d’America, o Atlantide che dir si voglia, verso la quale il nostro parte dal porto di La Rochelle un mattino di primavera, in compagnia d’una scombinata compagnia di eretici e di pendagli da forca, per ritrovarsi sballottato in un mondo davvero altro. Dove troverà, persino, quell’amore che per il nostro autore non è davvero motore delle umane cose e tanto meno musa di belle storie. Questo il libro. Dippiù, può dirsi che l’opera non è tutta farina del sacco del nostro, ma sunteggia e rivede un librone di ben 604 pagine stampato nel 1768 da un discendente del protagonista, sulla base del suo diario di bordo: Viaggio anacronistico nell’isola di Atlantide. Un viaggio vero? Falso? Lo stesso Vassalli non sa dirlo e neppure conta più che tanto sapere se il mancato prete Leonardo mise davvero piede nelle Americhe, che già allora si rivelarono una “stella avvelenata”. In un tempo posto a mezza via dalle Canarie riscoperte da Jean de Béthencourt quarant’anni prima, partendo proprio dallo stesso porto di La Rochelle, come primo passo per le Indie su cui Cristobal Colon avrebbe messo lo stendardo di Spagna, cinquant’anni dopo. Quel che più conta, ancora una volta, è che il nostro ha saputo raccontarci l’ennesima bella storia trascinandoci tra i marosi del tempo. E che questo, a non volerlo o poterlo cogliere a tempo, appunto, fuori d’ogni “anacronismo”, come recita il titolo, conduce al naufragio d’uomini e idee. Sogni compresi.
Bibliografia essenziale della critica
Roberto Cicala, La chimera. Storia e fortuna del romanzo di Sebastiano Vassalli, Interlinea, Novara, 2003. Un itinerario nella vita e nell’opera del nostro, curato da Roberto Cicala e Giovanni Tesio sul suo romanzo più famoso con materiale autobiografico, con parte della corrispondenza a Lolini poi edita in Belle lettere.
A firma Sebastiano Vassalli, con prefazione dello stesso Cicala, Terra d’acque, Interlinea, Novara, 2005. Novara e la sua storia in alcuni pezzulli del nostro, anche per il “Corriere della Sera”.
Cristina Nesi, Sebastiano Vassalli, Cadmo, Firenze 2005. L’unica biografia esistente.
Sulla Neoavanguardia e il Gruppo ’63
Guido Davico Bonino, Poesia della Neoavanguardia, in Dizionario critico della letteratura italiana, a cura di Vittore Branca, Utet, To 1986, vol. III.
Grana, Le avanguardie letterarie, Marzorati 1986.
Esposito, Le ideologie dell’avanguardia, Napoli 1976.
Si segnalano alcuni contributi all’interno di una bibliografia sterminata (a cura di Roberto Cicala, da: www.letteratura.it/vassalli):
Ioli, Introduzione a S. Vassalli, Ombre e destini, Napoli, Guida, 1983, pp. 5-8; G. L. Beccaria, La cometa della poesia, “L’Indice dei libri del mese”, 1 (1984); F. Sessi, La cometa, “Alfabeta”, 72 (1985); A. Gimmi, La notte della cometa, “Autografo”, 5 (1985); M. Bacigalupo, “Paragone”, 420 (1985), pp. 80-83; F. Portinari, L’Italia una e doppia, “L’Unità”, 23 dicembre 1987; L. Mondo, I bislacchi di Vassalli si raccontano all’Osteria del Genio, “La Stampa- Tuttolibri”, 16 gennaio 1988; S. Tamiozzo Goldmann, Abitare il tempo. Note su Sebastiano Vassalli narratore, “Autografo”, 19 (1990); M. Corti, Intervista a Sebastiano Vassalli, “Autografo”, 25 (1992); V. Viola, Introduzione a S. Vassalli, La chimera, Torino, Einaudi Scuola, 1990, pp. V-XIII; R. S. Crivelli, Zardino, ombelico del mondo dove nasce e muore il nulla, “Corriere di Novara”, 15 febbraio 1990; R. Cicala, Vassalli scava nel ’600 e trova il Nulla, “L’Azione”, 14 aprile 1990; F. Cordelli, Vassalli: La storia? Abita in queste stanze, “Corriere della Sera”, 10 ottobre 1996; Roberto Cicala, Un infinito numero, “Autografo”, 40 (2000), pp. 165-169; Giovanni Pacchiano, Vassalli, il vuoto dopo il ’68, “Sole-24 Ore”-“Domenica”, 17 giugno 2001; Lorenzo Mondo, I candidi eroi di Vassalli nell’Italia degli ideali a pezzi, in “La Stampa”-“Tuttolibri”, 23 giugno 2001. Sull’opera dello scrittore e sul suo romanzo più famoso si veda il volume: La chimera. Storia e fortuna del romanzo di Sebastiano Vassalli, a cura di Roberto Cicala e Giovanni Tesio (testi dello stesso Vassalli e di Carlo Bo, Gian Luigi Beccaria, Maria Corti, Umberto Bellintani), Novara, Interlinea-Centro Novarese di Studi Letterari, 2003.
Appendice: intervista di Maurizio Zuccari con Sebastiano Vassalli. Lo scrittore e la storia
(dicembre 2003, pubblicata sul sito Ragionamentidistoria e Mediazone.info)
Pezzo di Piemonte già Lombardia, Novara s’aggruma attorno alla basilica antonelliana di san Gaudenzio. Centomila anime, poco più. Poco oltre, qualche fabbrichetta, la De Agostini in primis, una landa di terra non ancora città, non più campagna, un tempo risaie. Col Monte rosa sullo sfondo, nelle giornate che non son di foschia. Ma la nebbia è scomparsa, dieci anni fa, puf! Di botto – racconta il tassista – quei bei nebbioni d’un tempo. Quella che sale adesso, nel piattume di campi a perdita d’orizzonte, vela solo l’occhio di chi è abituato ad altri cieli, capitato qui da fuori come per caso. Per raccontare la storia d’uno che racconta storie. Che partono da qui. Dalle ex risaie dove svettano pinnacoli con qualche casa appiccicata addosso, ogni tanto una cascina, una chiesola dismessa. Sebastiano Vassalli abita qui, fianco una cappella malmessa, dietro una doppia curva che si perde pei campi. Una piuma su un targhettino d’ottone al portoncino, come un vezzo letterario d’altri tempi. Quello che viene ad aprire è un signore gentile, quasi dimesso, sobrio e ben curato, che neppure mostra i sessanta superati da un po’. Un onesto borghese, come l’ha definito un sito internet ben giudicandolo assieme alla schiera dei contemporanei.
«Che sciocchezza, ma che vuol dire?», sbotta lui che internet manco sa cosa sia, il computer non lo usa, del telefonino ne fa a meno e nel salottino di casa – zeppo d’opere d’arte più o meno probabili – non campeggia neppure il televisore. E i suoi pezzulli al Corrierone li manda ancora per fax, battuti a macchina. «Oggi ho un rapporto di collaborazione fissa con un quotidiano e in omaggio alla mia età mi permettono di non avere queste tecnologie, faccio il mio pezzetto con la macchina da scrivere, poi lo mando per fax che è il massimo di tecnologia. Ma se fossi più giovane mi spiegherebbero quali sono le tecniche che usano nei giornali. Questi ferri vecchi resteranno in vigore finché non si estingueranno quelli della mia generazione».
E allora, con la tecnologia d’un registratorino e d’una stilo, cominciano sprofondati su divani nocciola. A partire dai luoghi. Da Genova a Novara: dal porto di mare al Monte Rosa. C’è – e se c’è, qual è – il rapporto fra scrittore e territorio o la terra dello scrittore è soprattutto la mente, il territorio del fantastico?
«Mah, il rapporto tra uno scrittore, come di qualunque altra attività intellettuale, e il luogo dove si vive c’è di sicuro, ma è un rapporto che non va inteso in senso angusto, nel senso che uno si occupa solo di ciò che vede dalla finestra. Il luogo può non entrarci per niente nell’opera dello scrittore, ma è indubbio che in qualche modo lo condiziona non foss’altro che come paesaggio, come orizzonti. Da lì a stabilire un netto rapporto ce ne corre. Io poi sono nato a Genova come sarei potuto nascere al Cairo. Non ho radici in quella città, mia madre è toscana, mio padre e tutta l’ascendenza paterna erano lombardi, addirittura ticinesi, Vassalli è un piccolo cognome del Canton Ticino. Lì non ci sono radici. Qui, da dove vivo ormai da più di cinquant’anni, ci sono sicuramente. Ma son rapporti profondi, sottili quelli con il luogo. Non sono e non devono essere, guai se lo fossero, rapporti di casa e bottega».
Perché Novara? Una casualità? E come è arrivato alla scrittura? Prima è passato dalla pittura alla poesia, alla ricerca linguistica. Tra gli anni ’60 e 70 è stato anche insegnante di letteratura.
«La vita è tutta casuale. Non è che uno a due anni dice: vado lì. In questi luoghi ci sono arrivato nell’infanzia, portato da altri. Io poi, guardi, non credo nel libero arbitrio nemmeno nell’età adulta. La maggior parte delle cose che facciamo… Ecco, gli sciocchi pensano: io ho deciso, ho voluto. La realtà è che di cose noi ne decidiamo e ne determiniamo ben poche. A vent’anni si tentano varie cose. Dipende da quando uno ha vent’anni. Io li avevo all’inizio degli anni ’60 ed era un periodo diversissimo da oggi, di grandi sperimentazioni. Arte e letteratura erano un fatto economico molto meno di quanto non siano oggi. C’erano le cosiddette avanguardie e quindi anche il passaggio da una ad un’altra espressione artistica era molto più banale, più normale di quanto non lo sia oggi. Oggi uno già sceglie. Allora no, chi voleva operare nelle arti operava su un orizzonte dove i confini tra la letteratura, pittura, musica, cinema e quant’atro erano estremamente labili e compenetrati l’uno nell’altro.
Subito dopo la laurea, cosa vuole, siamo sempre lì. Noi viviamo in un paese dove la professione dello scrittore è possibile da non molto tempo. Negli anni ’40, quando sono nato io, ma ancora negli anni ’50 e ’60, la professione dello scrittore di fatto non esisteva. Non c’era la figura dello scrittore che vivesse dei diritti d’autore, non c’era un pubblico sufficiente, un mercato librario. Era ancora una situazione ferma all’Ottocento, al Bonghi che si chiedeva perché in Italia non c’era una letteratura popolare. Il pubblico a cui si rivolgeva l’editoria, anche la saggistica, era un pubblico assolutamente ridotto, minoritario, di poche migliaia o decine di migliaia di persone. In questo non si era granché cresciuti dall’Ottocento.
La grande svolta di cui ancora oggi non ci rendiamo bene conto avviene tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’60, con il cosiddetto boom economico. Che poi era l’intersecarsi di tre cose, tre fenomeni questi sì epocali: l’industrializzazione con emigrazioni bibliche dal sud verso il nord, dalle campagne alle città. Si sono spostati milioni di persone, una migrazione biblica, gigantesca. La scolarizzazione all’inizio degli anni ’60, con l’obbligo scolastico esteso dalla quinta elementare, spesso disatteso, alla scuola media, obbligatoria di fatto oltre che di diritto. E poi la televisione, di cui da vent’anni si divertono a dire tutto il male possibile ma che ha rappresentato un grande passo in avanti per questo paese. Ha portato nelle case degli italiani un orizzonte di nozioni, di cognizioni che prima non c’erano. Questi tre fenomeni fanno sì che, da circa trent’anni, in questo paese sia possibile la professione dello scrittore. Prima di questo periodo scrittori che pure sono nella mia memoria, non facevano lo scrittore e basta. Italo Calvino, che ho conosciuto, lavorava per una casa editrice. Gadda lavorava per la televisione. A meno che non fossero di famiglia ricca, nobile e decaduta come Tomasi di Lampedusa, gran barone siciliano con le pezze sul culo che non faceva altro che passare le giornate al caffè e scrivere il Gattopardo, oppure Manzoni, ecco. Insomma, oggi in Italia è possibile fare lo scrittore come si fa l’avvocato, con la differenza che questi sono, che so, 900mila, gli scrittori che questo paese può permettersi saranno 80, 90. Quelli che fanno letteratura pura molti meno. Tornando al mio “particulare” io qualcosa dovevo fare, non potevo darmi alla libera professione. Avrei potuto fare altro, trovarmi qualche lavoretto in un giornale. Tutto sommato è stata meglio la scuola, perché allora era il lavoro da cui si entrava e si usciva più facilmente. Se avessi cominciato coi giornali o altri lavori più avvolgenti forse non mi sarei tirato fuori tanto bene».
Lei che è stato maestro, tra i suoi maestri colloca Dino Campana. Un’esistenza tormentata, una causa col suo paese acquisito, Marradi. Perché lui?
«Più che maestro è un babbo matto, il babbo adottivo. Ciò che mi ha avvicinato a lui, a parte il fatto che è uno dei pochissimi veri grandi del Novecento italiano e più si allontanerà questo secolo più rimarrà in scarsa compagnia. Adesso sembra che sian tanti ma lasci fare al tempo e vedrà che in capo a qualche decina d’anni… No, dicevo, la prima cosa che mi ha attirato a lui, ancora prima che ne conoscessi la sua grandezza, a parte il fatto che la sua è una vicenda spezzata, è questo dato comune, questo esserci scontrati da giovani con le avanguardie, queste fanfaluche che a me hanno fatto perdere molto tempo, a lui un po’ meno ma era un grande. Io invece ci ho perso degli anni. Ed erano balle, illusioni, cose di cui non valeva la pena. Però… Ecco, questa è la prima affinità che ho colto, poi il rapporto si è approfondito, articolato, è diventato un’adozione unilaterale dal basso verso l’alto».
Cosa direbbe a chi volesse darsi al mestiere di scrivere? Duetre consigli utili su cosa serve per fare lo scrittore.
«Guardi, oggi va di moda il genio. È molto più facile essere pubblicati. Se ripenso a quando ero giovane io era veramente, non so… Tutte le case editrici importanti in un anno potevano pubblicare, tutte insieme, una decina di esordienti. Oggi ogni anno gli esordienti sono alcune centinaia. Buona parte poi rimangono per strada, come è logico. Si crede nel genio, mentre io credo sia una gran balla. È un mito romantico, andava bene in un’epoca, fino a cento anni fa, quando la maggior parte della popolazione terrestre era analfabeta. E anche se sapeva leggere e scrivere non andava molto al di là. L’idea del genio è potuta prosperare in questa minoranza. In realtà credo che siamo tutti geni, più o meno. Data una certa base culturale, certo, c’è chi ha più talento per le matematiche, chi per le belle lettere, ma è un fatto abbastanza irrilevante. Credo molto, invece, ma molto, nel mestiere. La vera differenza la fa il mestiere, e questo in tutte le arti. Poi, quando uno è capace di fare una cosa, di organizzare una storia e di scriverla, di mettere giù una partitura musicale, di progettare e portare a temine un edificio.
Il fatto tecnico è fondamentale, poi può entrare in gioco il talento. Chi pensa di giocare sul genio e basta ha tutt’al più una trovata di quel momento. Oggi vedo tutti questi che esordiscono, gli sembra d’essere dei padreterni per qualche settimana o qualche mese, poi scompaiono, tutta gente che ha avuto l’illuminazione, il lampo di genio che non porta da nessuna parte. E mica è vero che gli esordienti non hanno mestiere, certo il mestiere si affina, si coltiva, poi si seguirà un percorso che porterà a sviluppare certe cose piuttosto che altre. Però, ecco, io credo nell’assoluta prevalenza di quello che chiamo mestiere, di tutto ciò che riguarda l’aspetto tecnico dello scrivere. Se uno non sa fare stare in piedi un libro, un racconto, può metterci tutto il genio che vuole ma non va da nessuna parte».
Perché il romanzo storico? Cito dalla presentazione de La Chimera: “per cercare le chiavi del presente, e per capirlo, bisogna uscire dal rumore: andare in fondo alla notte, o in fondo al nulla”. La narrazione storica come ricerca del presente, dunque?
«Il mio terreno sono le storie, più che la storia. Racconto delle storie. E queste possono essere anche frutto di un’invenzione. Esistono storie bellissime che nessuno ha mai raccontato. Basta levarsi dalla testa l’idea di raccontare la storia. La storia è un’idea che non esiste. Cioè va benissimo come materia scolastica, come segnaletica del tempo per chi segue un certo corso di studi che dica, che so, che l’impero romano è venuto prima della scoperta dell’America, che si sappia un po’ orientare nel passato, insomma. Che poi questa segnaletica ci racconti veramente il nostro passato, li ho qualche dubbio. Però senza quella segnaletica non si va da nessuna parte, è proprio come uno che vuol viaggiare nel mondo, deve per forza sapere che Berlino e di là, Parigi di qua, L’Africa laggiù. Così anche chi vuole avere una cognizione minima o massima delle vicende umane deve conoscere questa segnaletica. Faccio tanto di cappello, ma questa cosa non c’entra nulla col mio lavoro.
Poi c’è un’altra storia ancora, la parola ha molti significati, la storia come ideologia che nasce nel ‘700, strettamente legata all’idea di progresso, diventa una religione nell’800, il mito del progresso, e crolla miseramente nella nostra epoca che non a caso si è definita postmoderna. Ricordo uno scrittore morto già da qualche tempo, Giorgio Manganelli, dove in una mezza pagina strepitosa, di puro divertimento, quasi una barzelletta, prendeva in giro questo nostro rappresentare noi stessi come un esercito che avanza, perché la storia è questo: le famose tre domande del chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Sul chi siamo lo sappiamo e non lo sappiamo, idem da dove veniamo, quanto al dove andiamo, mah, Platone diceva che l’avvenire è sulle ginocchia di Zeus. Però la storia ci dice, un po’ come la mappa degli alberghi, ecco, voi siete qui. Quella storia lì non è mai esistita, non è mai esistita la storia di una vicenda comune di tutti gli esseri umani che progrediscono nel tempo. Ecco, la storia come progresso è l’ideologia del moderno che è venuta a naufragare nel nostro tempo.
Quindi noi, se dio vuole, non crediamo più alla storia e tanto meno possiamo scriverne, poi vabbè, le etichette… la faccenda del romanzo storico non esiste più, questo è figlio di un’epoca, l’800, che della storia ha fatto una religione, una fede ormai finita. Oggi si possono scrivere storie in tutte le direzioni, da tutte le parti: nel passato, nel futuro. Ho una grande ammirazione per Manzoni, ma la sua idea si è rivelata completamente sbagliata. Lui diceva che il romanzo storico è un componimento misto di storia e d’invenzione che sarebbe presto scomparso perché la storia, scienza del passato, con la sua luce avrebbe pian piano illuminato tutto e non ci sarebbe più stato nessuno spazio per l’invenzione. È successo esattamente il contrario. La storia non è una scienza, tanto meno esatta. E gli storici, quelli più noti, sono anzitutto dei grandi narratori. Uno dei maggiori storici moderni, Georges Duby, messo alle strette in un’intervista, definì la storia un récit, un racconto. Tanto che lo si può revisionare: si può negare che certi fatti siano accaduti, mettere in luce nei grandi eventi fatti che non lo sono: un racconto, insomma. Se parliamo di storia in questo senso mi va bene, arriviamo sul mio terreno. Ma la storia è una narrazione per tutti, con un elemento tragico. Perché chi ha creduto che la storia in quanto tale, oppure certe esperienze, potessero avere un valore salvifico se lo può dimenticare. Gli uomini continueranno ad imbrogliare le carte, a raccontarsi le cose come vogliono loro e prevarrà chi racconta di più, chi grida più forte. Quindi quest’idea della storia come scienza, come progresso, come ideologia, propria dell’800, è completamente finita».
Allora, non c’è la Storia con la s maiuscola, alla quale non crede, ma le piccole storie capaci di restituire al lettore – e prima di tutti all’autore – il quadro di un’epoca e agli interpreti un briciolo d’eternità, magari. È passato da una pluralità di stili, di personaggi e di epoche, da Benito Chetorni a Leonardo Sacco, aventi come comun denominatore le storie. Dallo sperimentalismo alla struttura narrativa tradizionale, codice biografico compreso. Perché? E qual è il più adatto a raccontare l’oggi? È solo una scelta letteraria o c’è qualcosa che vede là in fondo, sotto al cavalcavia?
«Ma no, lì c’è di mezzo questa faccenda delle avanguardie. Guardi, io sono diventato scrittore a quarant’anni, perché prima c’erano questi sperimentalismi. Ecco, prima ho detto di non credere ai geni, se lo fossi stato a vent’anni avrei detto: no all’avanguardia, agli sperimentalismi. Il mio mestiere è raccontare storie e avrei cominciato da allora, invece ho seguito un percorso più tortuoso. Insomma, è una questione generazionale, comunque io sono diventato scrittore dopo i quarant’anni. Non rifarei nulla di quello che ho fatto, sono due autori completamente diversi. D’altra parte si è figli della propria epoca, si appartiene ad una generazione. Se io non avessi fatto determinate esperienze probabilmente non sarei diventato neppure scrittore e non avrei cominciato a pubblicare. Chi ha la mia età doveva fare quel percorso lì. Se lei guarda, oggi di scrittori della mia età non ce n’è quasi, sono quasi tutti della generazione prima o dopo, la mia età è stata bruciata proprio perché chi ha cominciato come me con queste storie, il Gruppo ’63, gli esperimenti formali, poi ha continuato lì ed è miseramente finito. Evidentemente io avevo qualche ragione diversa e maggiore che mi ha permesso di riciclarmi, cosa che non ha fatto quasi nessuno.
Ecco, dicevamo all’inizio, io decido, faccio: balle. Nel momento in cui si nasce già si appartiene. Ad una comunità storica geografica, ad una nazione, chiamiamola così, anche se il termine non è granché bello. Si è legati ad una lingua, a dei genitori e ad una vicenda personale, quindi se si dovesse fare una somma, soltanto al momento della nascita, di tutto ciò che poi condizionerà l’individuo si capisce che già il 60% del libero arbitrio se ne va. Quell’altro 40% poi se ne va in corso d’opera. Quindi le scelte, la libertà, è un po’ un’utopia. Questo per dire che già il fatto di appartenere ad una generazione, cosa che prima non avevo messo nel conto, è un vincolo fortissimo. Vuol dire che cresci in mezzo a delle persone, ascoltando delle parole d’ordine, in un orizzonte culturale che è quello e poi cambierà, ma tu non lo sai che cambierà, a vent’anni non lo sai, tu vedi quello e pensi che il mondo sia assolutamente così, poi ti accorgi che cambia tutto».
Nelle sue pagine affiorano personaggi portatori d’una disillusione che sfiora il cinismo o, nel migliore dei casi, la rassegnazione, utili idioti. Da Cristiano Rigotti detto Cris ad Augusto Ricci, a Leo e Michela. Che rapporto c’è stato tra lei e la sinistra, i movimenti?
«Noi viviamo di miti, che poi più banalmente si traducono in sogni, illusioni. E una delle grandi illusioni della mia generazione e anche del mondo moderno è anche quella di cambiare il mondo. Ma è un’illusione che viene da lontano, c’è anche in altri miei personaggi, ad esempio nella Chimera il vescovo Bascapè era uno di quelli che volevano cambiare il mondo. Il suo sogno non era molto dissimile da quello dei bolscevichi russi che negli anni della rivoluzione scrivevano sui manifesti: con mano di ferro obbligheremo l’umanità ad essere felice. Ecco, per Bascapè sarebbe bastato sostituire una parola, santità con felicità, comunque il sogno è lo stesso, quello di cambiare il mondo. C’è una pagina felice di Benedetto croce, un autore a cui mi sento molto affezionato e per certi versi un suo nipotino, magari indegnamente, anche se lui era filosofo e io narratore, allora parlando di questo sogno nel ’45-’46 lui racconta in una pagina di diario della sua esperienza come ministro del governo Badoglio, subito dopo la guerra, quando incontra a Salerno due giovani comunisti o socialisti di vent’anni che vengono a nome del Cln. Lui li riceve molto amichevolmente, poi annota nel suo diario: due bravi ragazzi, sinceramente animati dalla volontà di guarire il mondo. Poi fa una specie di parentesi: strano ammalato, questo, che non è mai stato sano, per cui si deve credere che la sua condizione normale sia la malattia. Eppure, dice Croce, nel corso dei secoli tutti hanno cercato di guarire questo malato: chi con la religione, chi con la scienza, e adesso lo si vorrebbe guarire con l’economia. Però, dice Croce, il mondo continuerà ad essere quello che è e l’unico modo di migliorarlo non sarà quello di costruire grandi utopie, ma di far crescere il numero degli uomini di buona volontà e animati da buone intenzioni. È una cosa minimalista rispetto a quella massimalista, all’utopia di voler cambiare il mondo, ma mi sembra di un’attualità e di una forza assolute. Il mondo va dove deve andare.
Guardi, tre anni fa, l’11 settembre, il mondo ha aperto gli occhi su qualcosa che stava sucedendo da un mucchio di anni: il mondo era già cambiato. La gente se n’è accorta quando ha visto questo spettacolo mediatico in televisione, ma il mondo era già cambiato almeno dall’89, dalla caduta del muro di Berlino. Era da allora che tutti i parametri erano saltati, erano finiti i blocchi, le contrapposizioni, l’ideologia si era sciolta come neve al sole, si cominciava a capire che le guerre non erano più tali. I Balcani ci avevano insegnato che la guerra che si fa con le portaerei, con gli F 16, è un ferrovecchio del passato e invece vedevamo sotto i nostri occhi un’altra guerra, quella della cosiddetta pulizia etnica dove il nemico è da tutte le parti e in nessun posto. La caduta delle ideologie, la fine del progresso, la fine di un mondo i cui termini di riferimento erano riconoscibili, tutto ciò insomma era già accaduto.
Il mondo era già cambiato, ma non come avrebbero voluto quelli della mia generazione: era cambiato per conto suo, era diventato un’altra cosa. La gente ha cominciato ad accorgersene dopo l’11 settembre e se ne accorgerà sempre di più. Noi viviamo in un mondo in cui, mi dispiace per chi è anche obbligato a fare una certa politica, certe cose, le grandi tecnologie sono ferrivecchi. Il mondo è cambiato. La scommessa, di nuovo, è quella di acchiapparlo per la coda, di raccontarlo in questa sua metamorfosi in cui non abbiamo messo becco, almeno volontariamente. Se queste sue trasformazioni dipendessero dalle volontà umane sarebbe andato da tutt’altre parti, invece si è girato per conto suo e adesso la bravura dello scrittore è quella di corrergli dietro, anche perché corrergli davanti non può, non lo può nessuno. Questo oramai lo si è capito. Se una cosa si è potuta capire, dal ’68 ad oggi, è questa».
Perché le microstorie dovrebbero raccontarne più della storia? Quale dei suoi personaggi è più riuscito, in quest’ottica? Quale, cioè, le ha raccontato di più del vissuto d’un epoca e del nostro presente?
«I miei personaggi li ho scelti perché mi raccontavano qualcosa del presente, mica solo del passato. Magari le loro storie si svolgevano nel passato, prossimo o lontanissimo, addirittura nel futuro, però quello che interessa ad una persona che vive e lavora oggi è il tempo della sua vita, quindi è con quel metro che io ho disegnato le mie storie e tutte mi hanno insegnato qualcosa sul mio presente. Personaggi? Mah, non so, la storia della Chimera, ambientata nel Seicento, ci insegna che gli uomini hanno pochissime certezze nella loro vita: sanno che nascono, che dovranno morire e che passeranno la maggior parte del tempo che intercorre fra queste due date a infastidirsi fra di loro. Perché in generale il carattere assoluto delle storie umane è quello, no? Nell’orizzonte dei sentimenti umani ce ne sono anche di belli, di molto nobili, però il sentimento più forte, più durevole è l’odio e in questa parola se ne riassumono tante altre. Perché l’odio non è che una somma di altri sentimenti minori: l’invidia, la gelosia. Alcuni anche positivi, perché se non ci fossero questi sentimenti non belli, non lodevoli che spingono gli uomini a competere fra di loro, a contrastarsi in forme anche sgradevoli, pesanti, probabilmente non ci sarebbe stato neppure nessun progresso. Se gli uomini si fossero voluti bene dalla notte dei tempi sarebbero ancora lì che saltano da un ramo all’altro. E quindi questo sentimento è in pratica il motore di tutte le vicende umane. Gli uomini si odiano, in ciò c’è la radice di tutto ciò che li riguarda, il bello e il brutto. Però quest’odio man mano che l’incivilimento opera una certa trasformazione nei costumi assume forme più controllate.
Nel mondo di oggi gli uomini non si vogliono bene esattamente come non se ne volevano nel Seicento, ma la diversità in quanto tale non porta più a forme estreme come i roghi. Ma in questo capitolo della storia umana dell’inquisizione che serve a tenere tutto sotto controllo io non vedo una diretta responsabilità della chiesa. Il papa che ha chiesto scusa secondo me poteva anche risparmiarselo. In pratica invece è un momento molto particolare della vicenda umana in cui il diverso, chi non sottostà alle regole del “politicamente corretto” può anche lasciarci la pelle. In Italia questo tipo di odio si manifesta soprattutto nei confronti delle donne, delle streghe, in Spagna moltissimi furono mandati al rogo per omosessualità, in Francia ci furono persino condanne capitali per Licantropia. Quindi è una fase della vicenda umana che comunque avrebbe avuto quel risultato, la chiesa non fa niente altro che dargli dei rituali, la imbriglia, in qualche modo la frena. Dove non arrivarono i domenicani, gli inquisitori, come ad esempio nelle valli alpine, i vescovi delegavano i laici a giudicare di eresia e lì sono successe le cose più atroci. Ora, dicevo, la gente si odia ancora oggi come si odiava nel ‘500-600. Basta affacciarsi in un condominio, in un luogo di lavoro chiuso per capire che gli uomini non si vogliono bene. Però la gente non viene più bruciata. Non è il progresso di cui parlava Manganelli ma è già un bel passo avanti. Il mondo lentissimamente migliora».
Insomma, la vicenda di Antonia ci insegna che il motore della storia è l’odio.
«Beh, non semplifichiamo, eppoi l’odio non è un sentimento né piccolo né semplice. È una somma di tantissime cose ed è ciò che muove le vicende nostre. Senza l’odio non ci sarebbero più storie. Io chiudo bottega e domani mi trovo un altro mestiere. Altri sentimenti tipo l’amore sono acqua fresca, potrebbe sopravvivere in ogni paese una collana di Harmony, ma la letteratura finisce, guardi, la letteratura finisce».
È per questo che nelle sue opere non c’è mai molto spazio per l’amore, perlomeno nel senso tradizionale del termine? Anche l’ultimo suo protagonista, Leonardo Sacco, vive una storia d’amore, ma è sempre un po’ ai margini. L’amore insomma non sarebbe una buona musa?
«L’amore non produce grandi storie. Chiedo scusa a Romeo e Giulietta, ma insomma ogni regola ha le sue eccezioni che sono peraltro eccezioni parziali. Ci sono storie che commuovono, gratificano, ma non sono grandi storie. Le grandi storie e tutta la vicenda umana che le contiene è mossa da passioni di segno contrario. Ma dicendo questo non dico delle opinioni, penso di muovermi in un orizzonte di assoluto realismo. Che poi un certo tipo di letteratura funzioni perché vogliamo gratificarci, preferiamo un certo tipo di storielle anche insipide che però ci dicono che in fondo siamo buoni, bravi, caritatevoli, è dovuto al fatto che la nostra vera immagine non ci piace. Perché, chi la mattina quando si alza e si guarda nello specchio dice: che bell’ometto? È il momento in cui uno si piace meno, però è quella la nostra immagine vera. Io quindi faccio un tipo di letteratura che non produrrà mai best-seller folgoranti ma che punta di più a portare alla luce i meccanismi veri e profondi di ciò che muove le nostre storie vere, quelle che magari ci piacciono un po’ meno, che però sono più vicine al nostro vissuto».
La storia è andata oltre il mito, ma lei sostiene che uno scrittore deve saper costruire il mito, che un po’ cozza col senso d’una ricerca storica e può apparire un concetto pericoloso, nel senso che le storie o la storia dovrebbero servire proprio a destrutturare i miti, svelarne gli artifici. Spieghiamoci meglio.
«Eh, dovrebbe, sì, certo. La grande letteratura è quella che costruisce i miti. Noi, più tempo passa e più ci allontaniamo dalla possibilità, anche materiale, di produrre grandi opere che costruiscano un mito. Sul fatto che non ci sia contraddizione glielo dimostro subito. Il primo personaggio della letteratura occidentale e forse il primo personaggio in assoluto è Ulisse. Ulisse viene dalle profondità del tempo, Omero è stato uno dei tanti a raccontarcelo, chissà l’autore vero chi era, su questo personaggio gli antichi cantori hanno lavorato per secoli. Ulisse è colui che rende raccontabile un modo che prima di lui non era raccontabile. Perché era dominato dalle forze primordiali. Quindi prima di Ulisse c’erano la morte, la vita, la violenza cieca, la lussuria, l’incesto: un mondo in cui trionfavano gli istinti animali, l’uomo era a metà strada del suo percorso tra l’essere animale e l’essere sociale e civile che sta ancora cercando di diventare, però non poteva avere delle storie perché tutto si risolveva in questi episodi: uno incontrava un altro e lo accoppava, incontrava una donna e se la ingroppava. Nasceva, moriva, si ubriacava, questo era l’orizzonte. Ulisse trasforma questi istinti primordiali in altrettanti miti. La violenza cieca diventa il ciclope, la lussuria diventa la maga Circe, l’ebbrezza diventano i lotofagi, guidato dall’indovino Tiresia scende negli Inferi e racconta anche la morte. Dopo di lui il mondo è raccontabile. Cioè è una specie di gioco dell’oca in cui si costruiscono tutti o molti dei miti che poi saranno la base della letteratura moderna e occidentale. Certo, all’epoca in cui i cantori greci costruiscono questo personaggio i miti erano lì, a portata di mano. Non era facile neanche allora oggettivarli, però il mondo era tutto da raccontare. L’obiettivo, il sogno, l’approdo di uno scrittore è dare voce ad un mito. Questi oggi hanno già tutti molti voci, però lo scrittore degno di questo nome mira lì. Raccontare una storia grande, esemplare, utile, vuol dire oggettivare un mito, tirar fuori dal buio delle vicende e della psiche umana un elemento che muove le nostre azioni e fa che le nostre storie siano così e così. Il nostro tempo vive di miti, come tutti i tempi che l’anno preceduto e che lo seguiranno, ha bisogno di miti sempre più tecnicizzati, parcellizzati, e la letteratura cerca di dar voce a questi miti».
Lei ha titolato un suo libro di poesie il millennio che muore. Parafrasandolo, cosa vede invece in quello che nasce? Che tipo di presente è quello dell’oggi?
«Quello che le ho appena detto. Vedo delle trasformazioni che non controlliamo e che spesso non abbiamo neppure l’intelligenza di seguire. La superbia umana ci spingerebbe a cercare di controllarle comunque e lì nasceranno le sciagure che ci saremo meritati. Bisognerebbe invece capire che molte delle nostre vicende vanno per conto loro, cercare di assecondarle. Cercare di assecondare ciò che accade, non di dominarlo. Quando gli uomini hanno cercato di dominare le trasformazioni ne sono sempre usciti con la testa rotta. Ma come si fa? Gli interessi della politica del presente spingono in tutt’altra direzione. Lo scrittore però per mestiere deve essere capace di cogliere ciò che cambia.
Ancora per quelli della mia generazione questa utopia, ideologia, la si chiami come vuole, è stato un bel sogno, ho cercato di raccontarlo in questo mio libro, Cuore di pietra. Io giuro che non ci ho creduto mai, però quand’ero giovane mi sono imposto di crederci. Non era soltanto l’utopia in sé, addirittura qualcuno pretendeva che il marxismo fosse una scienza, ma era tutto quello che ci stava attaccato. Milioni, miliardi di uomini, generazione dopo generazione hanno sognato questo sogno. Tantissimi ci sono morti, son successe cose entusiasmanti, strazianti, nel nome di questo sogno. Eppoi in varie parti del mondo dappertutto è finito come doveva finire: in Germania è caduto il muro di Berlino, in Unione Sovietica si è disintegrato l’impero, qui da noi dall’oggi al domani si è scoperto che questo sogno di 150 anni, costato lacrime e sangue, era finito in certi conti cifrati in Lussemburgo. Certe ruberie. La nostra, con Tangentopoli, è stata la fine più grottesca, più pulcinellesca, insomma è finito dappertutto, in ogni paese alla sua maniera. Ma nonostante l’Italia fosse il paese dei Pulcinella anche qui è stato sognato sul serio, molti ci avevano lasciato la vita, gli avevano dedicato la vita. E quindi, ripeto, io mi ero imposto di crederci non perché credessi nella scientificità del marxismo, a quella non ho mai creduto, ma era necessario credere in qualcosa in cui avevano creduto tante persone, che aveva mosso tante passioni umane, tante speranza, tanti sogni, una cosa gigantesca poi sgonfiata».
C’è un lungo rapporto d’amore-odio tra intellettuali e Pci. Forse perché la logica del partito garantiva l’intellettuale, gli dava la possibilità di sentirsi parte di una famiglia, di un progetto più grande? E che rapporto c’è a questo punto tra lo scrittore e la solitudine. Quanto è importante questa nel mestiere di scrivere? C’era in un parco romano, fino a qualche tempo fa, un monumento che raffigurava il mestiere di scrivere come una sedia con una scrivania vuote, alte come un palazzo a più piani, per rappresentare proprio la dimensione della solitudine dello scrivere.
«Allora, il mio babbo matto, Dino Campana, diceva: tutto è sforzo individuale. Lui non si riferiva solo alla letteratura ma a tutte le arti, in particolare alla poesia. Anche lui avea incrociato un’esperienza di grupppo, quella dei futuristi, io quella del famoso “Gruppo ’63”. Le Avanguardie, nella letteratura e nell’arte occidentale, sono fenomeni ricorrenti e visto che stiamo parlando anche di marxismo io applicherei alle avanguardie quel famoso titolo che Lenin applicò all’estremismo: malattie senili dell’arte. Ce l’hanno solamente le culture vecchie e decrepite. La gran parte del mondo si è affacciata alla letteratura tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, poco più di un secolo fa. Interi continenti: l’America del sud, l’Oceania, l’Africa, grandi parti dell’Asia non avevano una letteratura. Hanno cominciato ada averla nel ‘900. La letteratura Latino Americana ci ha stupito perché quegli scrittori avevano ancora dei miti, non perché fossero più bravi. Noi quindi ci portiamo addosso queste malattie senili. Chi fa lo scrittore in un paese come l’Italia ha già una tradizione che si è consumata due lingue: il latino e l’italiano. Percorsi millenari, cosa vuole più raccontare? Però questa è una condizione di una parte dell’Europa, neppure di tutto il continente. Questo per dire che le cose non sono centrate come le vediamo noi.
Quanto poi al discorso del far gruppo, sentirsi parte di una famiglia, quello francamente no: anche quando amavo-odiavo la sinistra non l’ho mai sentita come una casa comune degli intellettuali. Le poche volte che per ingenuità giovanile mi ero avvicinato a quella sinistra mi ero accorto di essermi avvicinato ad un posto dove tutti gli spazi erano già affollati, le gerarchie già stabilite. Sì, sì, qualcuno ci stava bene, ma non era una casa comune degli intellettuali. Del resto ora quando vado a Roma la sento vuota, l’intelligencija era tutta lì, mica per niente Pasolini tirò fuori questa metafora strampalata del “palazzo”. L’intelligencija a Roma era proprio questo, una specie di palazzo dove erano già pronti i ruoli se la società si fosse spostata in un certo modo. C’erano i ministri, figure carismatiche: Moravia ministro in pectore, Guttuso altro ministro, e poi giù giù per li rami c’erano tutti gli altri personaggi, quasi tutti mezze calze. Tutto era molto gerarchizzato, il verbo arrivava dall’alto, sul fatto che ci fossero spazi veri di dibattito e di discussione, se uno come me che viveva nel Far West se lo fosse messo in testa bastava avvicinarsi a quella realtà per dimenticarselo. Però, ecco, la sinistra non intesa in questo senso fisico, perché lì veramente era la cosa più squallida e deludente che ci potesse essere, ma come circolazione di idee a livello planetario, questo era qualcosa di reale. Tutto ciò che si muoveva si muoveva lì, tra un’area di cultura liberale e una di cultura marxista. Non è mai esistita una cultura di destra. È inutile che noi adesso stiamo a dire la dittatura: no, ma quali dittature, semplicemente loro non c’erano, non ci sono e non ci sono mai stati. Ogni tanto fanno dei convegni ma, poveretti, come Manzoni diceva del coraggio di don Abbondio, così anche l’intelletto se uno non ce l’ha mica se lo può dare.
Quanto alla solitudine, adesso non si faccia fuorviare se vivo in questa dimensione. Da tre anni sono vedovo, i figli sono già grandi, e quindi mi vede anche materialmente… Però non c’entra un fico secco. Tra l’altro conosco dei luoghi in città, ci sono anche a Roma, dove uno vive nel massimo isolamento. Invece qui qualcuno viene ogni tanto a rompermi i coglioni, mi trovo una macchina parcheggiata davanti al cancello di gente che va alla ricerca di funghi. La vera condizione di aureo isolamento, la torre d’avorio, uno non se la sceglie in una campagna come la mia ma possono essere certi luoghi della Roma d’elites o di Milano. Lì a Montale rompevano le scatole molto meno che a me. Questo per quanto riguarda la solitudine fisica. Quanto all’altra non esiste, io adesso ho staccato tutto per stare tranquilli. Ormai viviamo nel villaggio globale, anche se uno come me ha fatto questa scelta, io ho un’età che posso permettermi di non avere a che fare con le nuove tecnologie e i personal computer. Se fossi più giovane non potrei permettermelo. Ma a parte questo, voglio dire il fatto che si vive in un villaggio globale, la solitudine non è una scelta, è qualcosa per cui bisogna lottare giorno per giorno, perché se lei entra nella mia ottica che le arti, tutte, e lo scrivere soprattutto, sono un lavoro in cui il mestiere predomina su quella della genialità le risulta anche che bisogna avere dello spazio per lavorare, non è che posso fare vite strane e poi mi raccolgo in una settimana in tempestosa creazione e tiro fuori Guerra e pace. Non esiste, un romanzo come quello ci vogliono anni per scriverlo, una dedizione assoluta, perché se vuole creare personaggi vivi e credibili lei può infondergli una vita sola che è la sua, se vuole creare un rapporto non superficiale o di sciocca genialità con questi personaggi.
E quindi bisogna difenderla, c’è bisogno di ore di lavoro quasi tutti i giorni e poi uno spazio di riflessione, perché di questo c’è bisogno. Che si deve difendere con le unghie e coi denti, ma questo non lo definirei tanto solitudine, perché è una solitudine molto ricca, molto piena di voci, insomma. Personalmente la preferisco di gran lunga al chiacchiericcio del presenzialismo, insomma. Io ho ancora da qualche parte di sopra un nastro di una segreteria telefonica di almeno quindici anni fa con la voce di Giulio Einaudi che mi dà del cretino – meno male che non c’ero, quindi se lo è preso la segreteria telefonica – perché non ero voluto andare da Maurizio Costanzo che c’era già alla fine degli anni ’80, anche se non era proprio una cosa pervasiva come oggi. Ero stato invitato e non c’ero andato e c’è questo nastro con la voce di Einaudi che dice, con questa voce un po’ nasale: ««Ho saputo che non sei voluto andare da Maurizio Costanzo. Pausa. Sei un cretino. Trac»». Ecco, queste sono le poche scelte che uno può fare, sono pochissime, però. Eh, noi siamo tutti proprio… La vita ci vive come vuole lei. Noi possiamo darle degli scatti, non sono granché. Per esempio in questo caso, tutto mi spingeva ad andarci, il fatto di avere un editore, di dover vendere dei libri, dovevo andarci, però lì ho preso una posizione netta e anche poco comprensibile da un certo punto di vista. E questo è ciò che lei chiama solitudine, che poi è la salvaguardia di alcuni spazi assolutamente necessari se si vuol fare questo mestiere in un certo modo».
È anche per questo che non ama i premi letterari?
«Oh beh, lì poi non è tanto presenzialismo, i premi letterari per come sono fatti in Italia è che ad una certa età se uno ha un po’ di rispetto per sé stesso, un po’ di dignità, dice basta. Sapevo che c’erano e facevano parte del mestiere dello scrittore, per un po’ ci sono anche andato dietro…».
Come Sanremo per i cantanti…
«Ma sì, certo, però vuol dire mangiarsi merda, rospi, li chiami come vuole, questa roba lì. Le cinquine, dove corre con il comico, l’attore, il politicastro che ha fatto le sue memorie, non so, e siete lì che correte, è come fare le corse dei cavalli o dei cani anzi peggio, io quelle le rispetto ma queste sono corse di cavalli con cani e galline, è una cosa… e poi questi sono i premi cosiddetti maggiori, a livello di quelli minori si scende veramente alle cose più terrificanti. C’è stato un fatto specifico per cui ho detto basta ai premi, per cui mi son detto non è più dignitoso. Saranno stati una decina di anni fa, mi telefonò persona di cui non faccio il nome, ancora viva, molto illustre, anziana, che mi disse: guarda, sai, noi facciamo questo premio in Toscana, erano cinque milioni, siamo tutti d’accordo, abbiamo deciso di darlo a te, però volevamo sapere se ci garantivi la presenza. Ho detto: va bene, era un settembre, mia moglie era ancora viva, mi son detto prendiamo la macchina, facciamo un bel giro in Toscana a trovare gli amici, eccetera. Stavo organizzando il tutto quando mi ritelefona questo e mi dice: no, scusa, guarda io proprio mi cospargo il capo di cenere ma non avevamo interpellato x, un altro nome tra i maggiori, che ha detto: eh no, no, quest’anno lo dobbiamo dare a y, che era un poeta. Questo ci muore, glielo dobbiamo dare. A Vassalli glielo diamo l’anno prossimo. E allora dietrofront e avanti marsc. E lì mi girarono talmente le scatole, ma fu la goccia che fece traboccare il vaso.
Non voglio insistere sull’argomento ma io ci son passato, ne ho anche presi tanti di premi letterari. Ci sono anche negli altri paesi, ma sono una cosa prevalentemente italiana, li abbiamo inventati noi. Altrove sono forse anche peggiori, sono di meno e più ricchi, premi di anche cento milioni come in Francia e in Spagna che da noi non esistono, in Germania. Quindi sono anche più trafficati, più sporchi. Da noi sono una cosa che ha a che fare con il costume nazionale. Una volta sono stato nel premio di poesia città di Ottaviano, che era l’epoca della camorra, e c’era questo Cutolo, tra l’altro poeta anche lui, l’Italia è piena di poeti… e c’era il segretario del premio, un napoletano all’epoca giovane ricercatore e oggi barone universitario, e una volta gli si affiancò uno stranissimo personaggio con dei baffoni neri che disse: questo premio si fa per quest’anno, poi non si farà più. Lui lo guardava e questo, l’inquietante, disse ancora: a noi di xy non ce ne fotte niente, ma suo padre era un uomo d’onore. Ha voluto il premio e glielo facciamo, ma per un anno. Insomma il premio lo demmo a Sanguineti. Sanguineti venne a Ottaviano a prendersi il premio lo stesso giorno del funerale di un sindacalista che era stato sparato in piazza. E questa è l’Italia, si fanno premi letterari in paesi dove non ci sono le fognature. I premi letterari sono una cosa… Così, dopo aver soggiaciuto a questi rituali per decenni, ad un certo punto ho deciso di tirarmene fuori. La cosa non è stata apprezzata, garantisco, perché i miei colleghi scrittori amano, molto, i premi, e tuttora nell’ambiente si fa finta che io non me ne sia tirato fuori. Se qualcuno ne parla in privato dice: quello stronzo, chi crede di essere. Invece, ripeto, è stato proprio un fatto di dignità, niente di più».
La sua è stata una lunga ricerca del carattere nazionale degli italiani, attraverso i suoi personaggi, ma anche libri-inchiesta come Sangue e suolo. Una ricerca che l’ha spinta a dire, come il libro “ricopertinato” da Baldini & Castoldi che Gli italiani sono gli altri. Ma chi sono questi altri?
«Vede, tra l’altro questa cosa della ricopertinatura mi ha fatto girare un po’ le scatole, perché se l’editore avesse avuto un po’ d’intelligenza nel ’98 questo era un libro che aveva una sua novità, adesso tutti parlano di carattere nazionale. Ricordo che negli anni’70-’80 che mi interrogavo sul nostro carattere nazionale, quando la parola veniva guardata con sospetto e allora il carattere nazionale italiano è molto complesso, faremmo mattina se cominciassimo a parlarne. Però se proprio dovessimo andare a dire uno, due punti, a parte la lingua, per i quali tu riconosci un italiano, senza dubbi, cioè cosa connota di primo acchito un italiano, beh, per esempio ricordo, adesso questo fenomeno si sta un po’ attenuando, ma per decenni e decenni, dal dopoguerra, il primo connotato del carattere nazionale degli italiani è stata la convinzione di non avere un carattere nazionale. Invece ce l’avevano e ce l’hanno eccome e forse è più forte di quello dei tedeschi o degli inglesi, però loro sono convinti di non averlo. E di lì i tanti equivoci, ecco, gli italiani sono gli altri. Se lei va al sud da Roma in giù tutti i mali del singolo e della comunità vengono dal nord. Ma se va a parlare con Bossi & company le diranno che tutti i mali della Padania e dintorni vengono dal sud, da questo sud che è come un bubbone attaccato a un corpo sano.
Questo a livello macroscopico, a livello microscopico il sistema di identità entra in crisi di fronte, non so, al pagare le tasse, al misurarsi con cose civile come la raccolta differenziata, allora chi dovrebbe fare una certa cosa si pone in un certo modo alternativo: lo facciano loro. E questi loro sono gli italiani, io sono al di sopra e al di fuori, io non mi riconosco. Io rinuncio alla cittadinanza italiana, diceva Pasolini che era un italiano al cubo. Sciascia si identificava con la Francia e il secolo dei lumi, lui non era mai stato italiano, scherziamo, però passato lo stretto diventava siciliano in servizio permanente effettivo. Il Moravia del non con lo stato né con le Brigate rosse. Ma, signor Moravia, cos’è questo stato? Lei vive a Roma, quando fa buio accende la luce, quando ha la mondezza la butta, non so, allora queste cose se le fa fare dalle Brigate rosse? Non so, capisce cosa vuol dire gli italiani sono gli altri? Chi è nato come me durante l’ultima guerra è vissuto in un paese schizofrenico. A livello poi di intellettuali, di quelli cioè che avrebbero dovuto avere le ideee più chiare di quelle di altri, lì si entrava nella follia pura. Ma lasciamo stare…».
Per finire. Quale sarà la prossima bella storia da cui farsi trasportare? Ce l’ha?
«Certo che ce l’ho, ne ho tante, ma non ne parlo perché sono superstizioso. C’è un mio libro, Un infinito numero, che si apre con l’immagine mia, del mio giardino, con i miei personaggi… Ma è tutto vero, sa, son lì che aspettano, come nell’anticamera del dottore. Io non rimarrò mai a corto di storie».
(a cura di Maurizio Zuccari, Laboratorio di scrittura e cultura della comunicazione della facoltà di Scienze della comunicazione dell’università La Sapienza di Roma)
Scheda biobibliografica sull’autore
Il sito di Sebastiano Vassalli
infocentro@letteratura.it